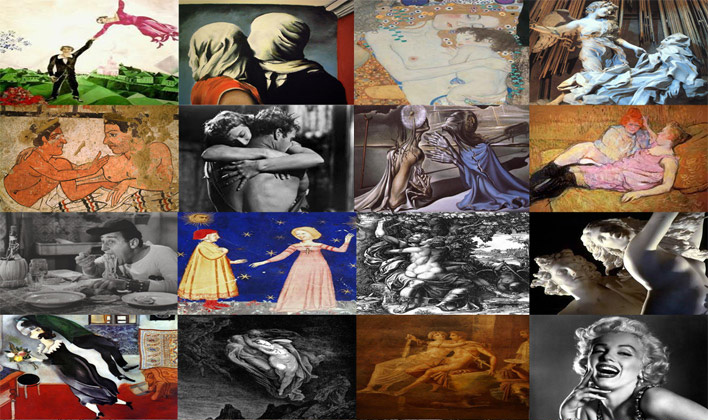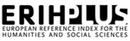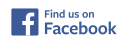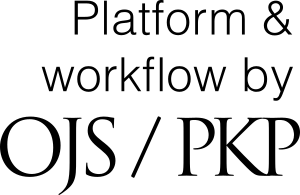Attilio Scuderi, Il paradosso di Proteo
Abstract
Review of the book Il paradosso di Proteo.Downloads
References
Copyright Notice
You are free to copy, distribute and transmit the work, and to adapt the work. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).