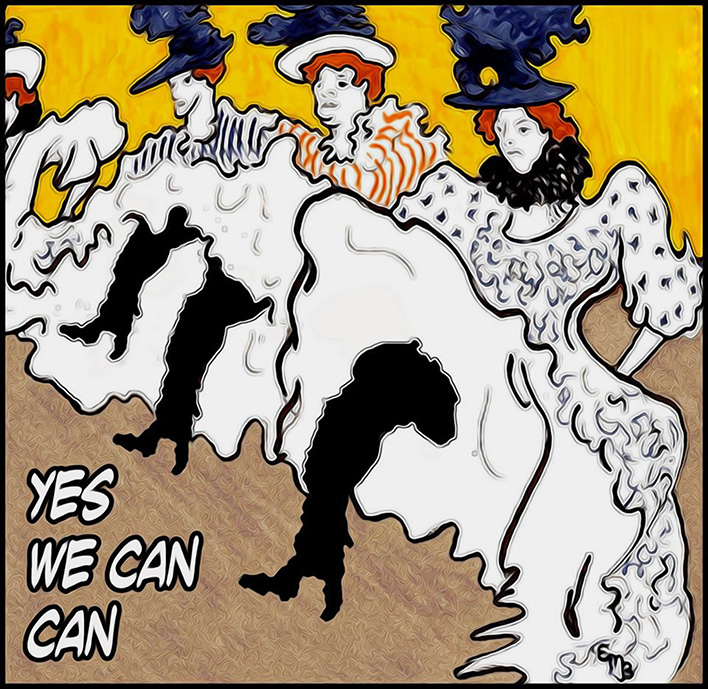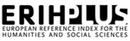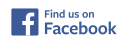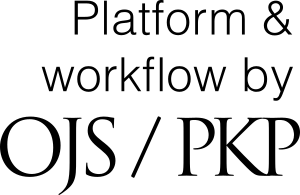The Three Ages of Laughter
Abstract
This essay presents itself as theoretical introduction to the question of humour (in its basic articulation among parodic, satirical and anti-narrative forms). It offers a concise excursus among the various sections of the volume resulting from the Compalit Conference Who Laughs Last: Parody Satire Humour held in Naples (16-18 December 2015): from the plenary lectures of the first section to the papers developed in the other five sections focused on, respectively: the examination of the present heuristic effectiveness of Bakhtin’s theory; an investigation on parodies of the sacred in contemporary literature and fine arts; a genealogy of anti-narrative writing ascribable to the archetype of Sterne’s Tristram Shandy; a morphology of the literary works marked by “dianoetic laugh” and apocalyptic humour; the transmedia crossing of the “palimpsests” of the 20th century, with a particular reference to theatre and cinema (but also to television, comics and the web).Downloads
References
Alfano, Giancarlo (ed.), La satira in versi. Storia di un genere letterario europeo, Roma, Carocci, 2015.
Attardo, Salvatore, Linguistic theories of Humor, Berlin – New York, Mouton de Gruyter, 1994.
Auerbach, Eric, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale (1953), trad. it. di Alberto Romagnoli – Hans Hinterhäuser, Torino, Einaudi, 2000, 2 voll.
Bachtin, Michail Michajlovič, L’opera di Rabelais e la cultura popolare. Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e rinascimentale (1965), Ed. Mili Romano, Torino, Einaudi, 1979.
Id., “La parola nel romanzo”, Id. Estetica e romanzo. Un contributo fondamentale alla «scienza della letteratura», Ed. C. Strada Janovič, Torino, Einaudi, 1979: 83-108.
Bergson, Henri, Le Rire. Essai sur la signification du comique, Édition Alcan, Paris, 1900.
Bertoni, Clotilde, Percorsi europei dell’eroicomico, Pisa, Nistri-Lischi, 1997.
Boitani, Piero, Ri-Scritture, Bologna, il Mulino, 1997.
Breton, André, Antologia dell’humour nero (1939), Eds. Mariella Rossetti – Ippolito Simonis, Torino, Einaudi, 1977.
Émelina, Jean, Le Comique: Essai d’interprétation générale, Paris, Sedes, 1991.
Ferroni, Giulio, Il comico nelle teorie contemporanee, Roma, Bulzoni, 1974.
Frye, Northrop, The Great Code. Bible and Literature (1982), San Diego-New York – London, Harvest, 1983.
Freud, Sigmund, Il motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio (1905), trad. it. di S. Daniele – E. Sagittario, Torino, Bollati Boringhieri, Torino 1975.
Genette, Genette, Palinsesti. La letteratura al secondo grado (1982), trad. it. di Raffaella Novità, Torino, Einaudi, 1997.
Grojnowki, Daniel, Aux Commencements du rire moderne: l’esprit fumiste, Paris, José Corti, 1997.
Hamon, Philippe, L’Ironie littéraire. Essai sur les formes de l’écriture oblique, Paris, Hachette, 1996.
Hutcheon, Linda, A Theory of Parody, Methuen, London, 1985.
Ead., “Beginning to Theorise Postmodernism”, Textual Practice, 1.1 (1987): 10-31.
Lukács G., L’anima e le forme (1911), Ed. Sergio Bologna, Milano, SE, 1991.
Mazzacurati, Giancarlo (ed.), Effetto Sterne. La narrazione umoristica in Italia da Foscolo a Pirandello, Pisa, Nistri-Lischi, 1990.
Mazzoni, Guido, Teoria del romanzo, Bologna, il Mulino, 2011.
Minois, Georges, Storia del riso e della derisione (2002), trad. it. di Manuela Carbone, Bari, Dedalo, 2004.
Olbrechts-Tyteca, Lucie, Il comico della retorica (1974), Milano, Feltrinelli, 1977.
Pirandello, Luigi, L’umorismo (1908), Ed. Nino Borsellino, Milano, Garzanti, 1995.
Plebe, A., La teoria del comico da Aristotele a Plutarco, Torino, Università di Torino, 1952.
Propp, Vladimir Jakovlevič, Comicità e riso: letteratura e vita quotidiana, Ed. Giampaolo Gandolfo, Torino, Einaudi, 1988.
Scaiola, Anna Maria, Dissonanze del grottesco nel romanticismo francese, Roma, Bulzoni, 1988.
Tynjanov, Jurij N., “Sulla parodia”, Dialettiche della parodia, Ed. Massimo Bonafin, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1997: 25-48.
Copyright Notice
You are free to copy, distribute and transmit the work, and to adapt the work. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).