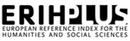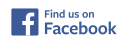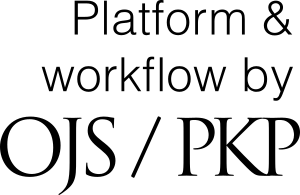Early Twentieth-Century: what is the attack against the tragic, what its defense
Abstract
Between the last few years of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century the tragic discourse went through a significant revaluation. This, practically embodied in Henrik Ibsen, found expression both in the theoretical work of authors such as György Lukács and Otto Weininger, and in the artistic production of figures such as Hugo von Hofmannsthal or – in Italy – Scipio Slataper and Giovanni Boine. Early twentieth century tragic discourse represents an attempt to react to the epistemological crisis that – differently interpreted by authors such as Henri Bergson, Ernst Mach and clearly Friedrich Nietzsche – is imposing as the hegemonic thought of the first part of the century. Early twentieth century tragic discourse was therefore one of the main actors in the philosophical and artistic confrontation the followed the announcement of the “death of God”. It is actually possible to say that Modernist tragic represented one of the most effective weapons for those intellectuals that did not consider positively the cultural horizons embodied by nihilism and relativism. My article, on the one hand, briefly delineates the clash between tragic and anti-tragic conceptions in early twentieth century, clarifying the theoretical genealogies that underlined the two positions. On the other the article points out the connections between the two positions and structural developments of the time (Taylorism, specialization, atomization, etc.)Downloads
References
Amendola, Giovanni, Etica e biografia, Milano, Ricciardi, 1963.
Bergson, Henri, La filosofia dell’intuizione, Lanciano, Carabba, 1910.
Boine, Giovanni, Plausi e botte, Firenze, Vallecchi, 1978.
Id., Il peccato, Plausi e botte, Frantumi, Altri scritti, a cura di Davide Puccini, Milano, Garzanti, 1983.
Id., Carteggio, vol. IV, a cura di Margherita Marchione e Samuel Eugene Scalia, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1979.
Cacciari, Massimo, Metropolis: saggi sulla grande città di Sombart, Endell, Scheffler e Simmel, Roma, Officina, 1973.
Lukács, György, Cultura estetica, Roma, Newton Company, 1977.
Id., Diario (1910-1911), Milano, Adelphi, 1983.
Id., L’anima e le forme, Milano, SE, 2002.
Mach, Ernst, Analisi delle sensazioni, Torino, Bocca, 1903.
Manfreda, Luigi Antonio, Aporie del simbolo: saggio su Otto Weininger, Napoli, Liguori, 1995.
Mann, Thomas, Considerazioni di un impolitico, Milano, Adelphi, 2005.
Michelstaedter, Carlo, Scritti scolastici, a cura di Sergio Campailla, Gorizia, Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei, 1976.
Musil, Robert, L’uomo senza qualità, Milano, Mondadori, 1992.
Id., Diari: 1899-1941, a cura di Adolf Frisé, Torino, Einaudi, 1980.
Nietzsche, Friedrich, Al di là del bene e del male, Torino, Bocca, 1898.
Id., Così parlò Zarathustra, Torino, Bocca, 1899.
Palazzeschi, Aldo, Tutti i romanzi, vol. II, a cura di Gino Tellini, Milano, Mondadori, 2005.
Pirandello, Luigi, L’umorismo e altri saggi, a cura di Enrico Ghidetti, Firenze, Giunti, 1994.
Id., “Non conclude”, in Giancarlo Mazzacurati, Pirandello nel romanzo europeo, Bologna, Il Mulino, 1987.
Prezzolini, Giuseppe, Il linguaggio come causa d’errore. Henri Bergson, Firenze, Spinelli, 1904.
Serra, Renato, Le lettere, a cura di Giuliana Benvenuti e Luigi Weber, Bologna, CLUEB, 2006.
Slataper, Scipio, Ibsen, Firenze, Sansoni, 1944.
Id., Appunti e note di diario, a cura di Gianni Stuparich, Milano, Mondadori, 1953.
Id., Scritti letterari e critici, Milano, Mondadori, 1956.
Id., La nostra epica, in La Città. Rivista bimestrale di lettere e arti, a cura di Marcello Pirro, n. 6, dicembre 1964.
Soffici, Ardengo, Giovanni Boine, in Rete Mediterranea, II, giugno 1920.
Id., “L’impressionismo e la pittura italiana”, Opere, vol. I, Firenze, Vallecchi, 1959.
Id., “Anna Gerebzova”, Opere, vol. I, Firenze, Vallecchi, 1959.
Id., “Primi principi di un’estetica futurista”, Opere, vol. I, Firenze, Vallecchi, 1959.
Id., “Arlecchino”, Opere, vol. II, Firenze, Vallecchi, 1959.
Id., “Autoritratto di artista italiano nel quadro del suo tempo, Opere, vol. II, Firenze, Vallecchi, 1968.
Stuparich, Carlo, Cose e ombre di uno, Roma, Sciascia, 1968.
Szondi, Péter, Saggio sul tragico, Torino, Einaudi, 1996.
Weininger, Otto, Delle cose ultime, Pordenone, Edizioni Studio Tesi, 1992.
Copyright Notice
You are free to copy, distribute and transmit the work, and to adapt the work. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).