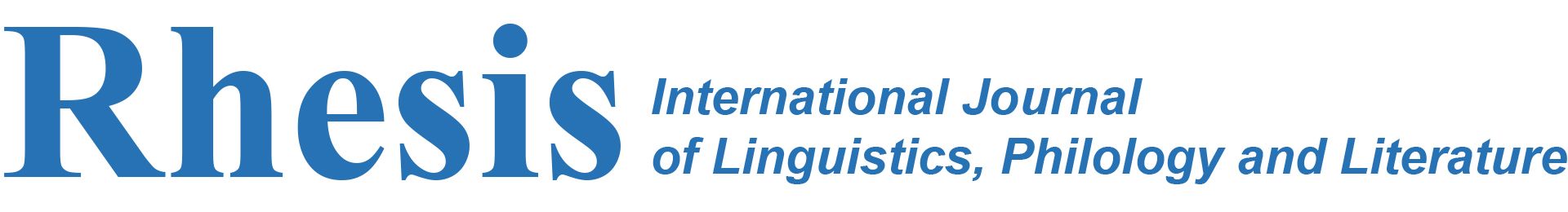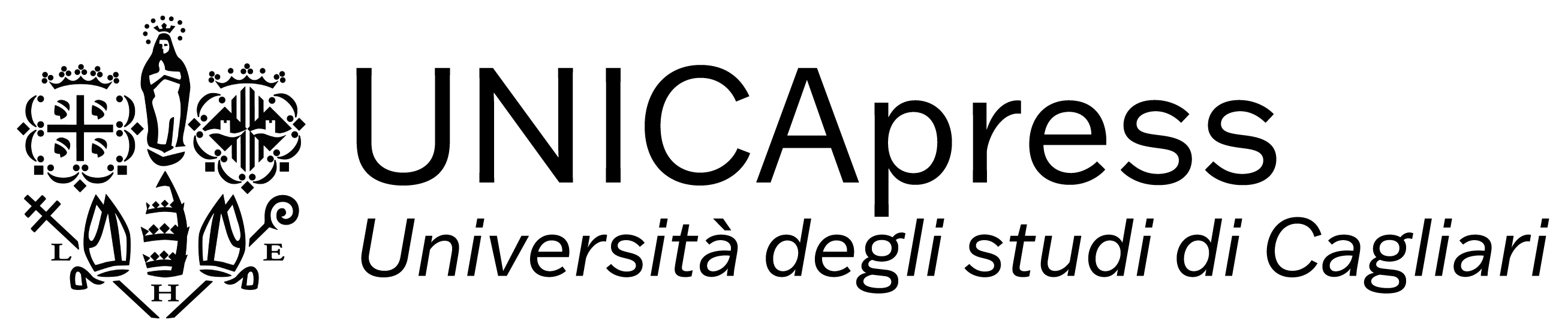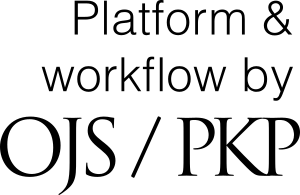Dal latino all’italiano: una storia di parole
Abstract
This essay offers an overview of the relationships that connect the Italian and Latin lexicon, highlighting the peculiarity of the Italian language in the context of Romance languages. The phonological proximity of Tuscan to Latin has favored the insertion of a vast number of learned words, creating a latinization of the Italian lexicon to an extent that is greater than for any other Romance language. In the formation processes of the Italian language, the influx of learned words played a role no less important than that played by the entry of popular words. Hereditary words are more rooted in areas of daily life and material culture; Latinisms have left a greater imprint on the abstract intellectual lexicon and have been of fundamental importance in the constitution of an international scientific lexicon, but they also deeply pervade the basic vocabulary. The language of ancient Rome has left its mark on the European lexicon because it was also the medium for introducing a conspicuous number of Greek words into Romance and non-Romance languages. Within Italian language, popular words and learned words are not two rigidly separated blocks: the linguistic reality, in fact, turns out to be more complex than these schematic distinctions because of the continuous relationship of interchange between the two nuclei traditionally identified with the learned and popular labels. The creation of a third category, that of half-learned words, only apparently solves the problem and confirms that the popular tradition and the learned tradition are clearly not separate channels. The essay highlights how the interweaving of words of different origin gives life in Italian to complex families of words, each of which presents a different story that is the result of crossings and migrations from one language to another. In particular, the study focuses on the analysis of a high number of allotropes, whose historical path, semantic development and phonetic evolution are outlined. Ample space is dedicated to the characters and phenomena of the Vulgar Latin lexicon: the loss of the less common synonyms, the disappearance of homophones, the replacement of short words with longer words or of generic words with specific and expressive words or of single words with syntagms, the substitution of diminutives for basic forms or frequentative and intensive verbs for simple verbs, semantic broadening and narrowing, and the coining of new verbs. A linguistic revolution of this magnitude was favored by the advent of Christianity: a religion that made the primacy of the least important person one of the cornerstones of its message, and which therefore operated a complete reversal of the social hierarchy could not fail to adopt a sermo humilis that was close to the language of the people and was thus easily understood by the faithful masses. The influence of Christianity is investigated through the examination of three guiding threads: Hebrew words that entered Christian Latin through Greek; words of Christian Latin derived from Greek; and semantic changes in Christian Latin. In this excursus the contribution of Latin to Italian is observed through the visual angle of words, of which historical events are reconstructed in an imaginary journey from the past to the present.
Downloads
References
Bartoli, Matteo (1936), ‘Caratteri fondamentali della lingua nazionale italiana e delle lingue sorelle’, Miscellanea della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino, 1, 70-106.
Bruni, Francesco (1984), L’italiano. Elementi di storia della lingua e della cultura. Testi e documenti, Torino, UTET.
Burgassi, Cosimo; Guadagnini, Elisa (2017), ‘L’integrazione lessicale di facile nel vocabolario italiano’, in Guadagnini, Elisa; Vaccaro, Giulio (eds.), «Rem tene, verba sequentur». Latinità e medioevo romanzo: testi e lingue in contatto, Atti del convegno conclusivo del progetto FIRB – Futuro in ricerca 2010 «DiVo – Dizionario dei Volgarizzamenti. Il lessico di traduzione dal latino nell’italiano delle Origini» (Firenze, Villa Medicea di Castello, 17-18 febbraio 2016), 157-177.
Castellani, Arrigo (1973), I più antichi testi italiani, Bologna, Pàtron Editore. Castellani, Arrigo (1980), Saggi di linguistica e filologia italiana e romanza (1946-1976), 3 voll., Roma, Salerno Editrice.
Castellani, Arrigo (2000), Grammatica storica della lingua italiana, Bologna, il Mulino, vol. I: Introduzione.
Cella, Roberta (2003), I gallicismi nei testi dell'italiano antico (dalle origini alla fine del sec. XIV), Firenze, Accademia della Crusca.
Contini, Gianfranco (1970), Varianti e altra linguistica. Una raccolta di saggi (1938-1968), Torino, Einaudi.
Cortelazzo, Manlio (1988), ‘Etimologia e storia del lessico’, in Holtus, Günter; Metzeltin, Michael; Schmitt, Christian (eds.), Lexikon der Romanistischen Linguistik, Tübingen, Niemeyer, vol. IV, 401-419.
D’Achille, Paolo (2010), ‘Allotropi’, in ENCIT, 53.
Dardano, Maurizio (1994), ‘I linguaggi scientifici’, in Serianni, Luca; Trifone, Pietro (eds.), Storia della lingua italiana, 3 voll., Torino, Einaudi, vol. II (Scritto e parlato), 497-551.
DBI = Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1961 e segg.
DEI = Battisti, Carlo; Alessio, Giovanni (1975) [1950-1957], Dizionario Etimologico Italiano, 5 voll., Firenze, G. Barbèra Editore.
DELI = Cortelazzo, Manlio; Zolli, Paolo (1999) [5 voll., 1979-1988], Dizionario Etimologico della Lingua Italiana, 2° ed. in vol. unico a cura di Manlio Cortelazzo e Michele A. Cortelazzo, Bologna, Zanichelli.
De Mauro, Tullio (1980), ‘Il vocabolario di base della lingua italiana’, in De Mauro, Tullio, Guida all’uso delle parole. Parlare e scrivere semplice e preciso per capire e farsi capire, Roma, Editori Riuniti, 149-183 (appendice).
De Mauro, Tullio (1999), Postfazione, in GRADIT, vol. VI, 1163-1183.
De Mauro, Tullio (2000), ‘Stratificazioni sociolinguistiche dell’eredità latina e dei suoi tramiti in italiano’, in Cipriano, Palmira; D’Avino, Rita; Di Giovine, Paolo (eds.), Linguistica storica e sociolinguistica, Atti del Convegno della Società Italiana di Glottologia (Roma, 22-24 ottobre 1998), Roma, Il Calamo, 163-188 (ora in De Mauro 2005, 193-218).
De Mauro, Tullio (2005), La fabbrica delle parole. Il lessico e problemi di lessicologia, elaborazioni statistiche e indici a cura di Clara Allasia, Torino, UTET.
De Mauro, Tullio; Chiari, Isabella (2016), Il Nuovo vocabolario di base della lingua italiana, con la collaborazione di Francesca Ferrucci,
Devoto, Giacomo (1974), Il linguaggio d’Italia. Storia e strutture linguistiche italiane dalla preistoria ai nostri giorni, Milano, Rizzoli.
DOP = Dizionario italiano multimediale e multilingue d’ortografia e di pronunzia, redatto in origine da Bruno Migliorini, Carlo Tagliavini e Piero Fiorelli, riveduto, aggiornato, accresciuto da Piero Fiorelli e Tommaso Francesco Borri, Roma, RAIERI, 2010 [1969]
Durante, Marcello (1981), Dal latino all’italiano moderno. Saggio di storia linguistica e culturale, Bologna, Zanichelli.
Enc. Dant. = Enciclopedia Dantesca, diretta da Umberto Bosco, 6 voll., Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1984 [1970-1978]
ENCIT = Enciclopedia dell’italiano, diretta da Raffaele Simone, con la collaborazione di Gaetano Berruto e Paolo D’Achille, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2010
Fanfani, Massimo (1996), ‘Sugli anglicismi nell’italiano contemporaneo (XIV)’, Lingua nostra 57, 72-92.
Fiorelli, Piero (2008), Intorno alle parole del diritto, Milano, Giuffrè Editore.
GDLI = Grande Dizionario della Lingua Italiana, fondato da Salvatore Battaglia, diretto da Giorgio Bárberi Squarotti, 21 voll., Torino, Utet, 1961-2002, integrato da 2 voll., Supplemento 2004 e Supplemento 2009, diretti da Edoardo Sanguineti, 2004 e 2008.
Giovanardi, Claudio (1994), ‘Il bilinguismo italiano-latino del medioevo e del Rinascimento’, in Serianni, Luca; Trifone, Pietro (eds.), Storia della lingua italiana, 3 voll., Torino, Einaudi, vol. II (Scritto e parlato), 435-467.
GRADIT = Grande dizionario italiano dell’uso, ideato e diretto da Tullio De Mauro, con la collaborazione di Giulio C. Lepschy e Edoardo Sanguineti, 6 voll., Torino, Utet, 1999, integrato da 2 voll., Nuove parole italiane dell’uso, 2003 e 2007.
Harnack, Adolf von (1906) [1902], Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, Leipzig, J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 2 voll., vol. I (Die Mission in Wort und Tat).
Lapucci, Carlo (2006), Dizionario dei proverbi italiani, Firenze, Le Monnier.
LEI = Lessico Etimologico Italiano, diretto da Max Pfister e Wolfgang Schweickard, Wiesbaden, Reichert, 1979 e segg.
LIP = De Mauro, Tullio; Mancini, Federico; Vedovelli, Massimo; Voghera, Miriam (1993), Lessico di frequenza dell’italiano parlato, Milano, Etaslibri.
Lorenzetti, Luca (2010), ‘Lessico’, in ENCIT, 778-784.
Maiden, Martin (1998), Storia linguistica dell’italiano [A linguistic history of Italian], tradotto da Pietro Maturi, Bologna, il Mulino.
Mancini, Marco (1992), L’esotismo nel lessico italiano, Viterbo, Università degli studi della Tuscia – Istituto di studi romanzi.
Marazzini, Claudio (1994), La lingua italiana. Profilo storico, Bologna, il Mulino.
Migliorini, Bruno (1942), ‘Appendice al Dizionario moderno’, in Alfredo Panzini, Dizionario Moderno. Le parole che non si trovano negli altri dizionari, ottava edizione rinnovata, Milano, Hoepli, 761-879.
Migliorini, Bruno (1945), Pronunzia fiorentina o pronunzia romana?, Firenze, Sansoni.
Migliorini, Bruno (1973), Lingua d’oggi e di ieri, Caltanissetta-Roma, Sciascia.
Migliorini, Bruno (1988) [1960], Storia della lingua italiana, introduzione di Ghino Ghinassi, 2 voll. Firenze, Sansoni.
Migliorini, Bruno (1990), La lingua italiana nel Novecento, a cura di Massimo L. Fanfani, con un saggio introduttivo di Ghino Ghinassi, Firenze, Le Lettere.
Nocentini, Alberto (2010), l’Etimologico. Vocabolario della lingua italiana, con la collaborazione di Alessandro Parenti, Milano, Le Monnier-Mondadori Education.
Pagliaro, Antonino (1955), ‘Da missa est a missa «messa»’, Rendiconti della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche dell’Accademia Nazionale dei Lincei, serie 8, 10 (3-4), 103-135.
Pellegrini, Giovan Battista (1972), Gli arabismi nelle lingue neolatine con speciale riguardo all’Italia, 2 voll., Brescia, Paideia Editrice.
Pellegrini, Giovan Battista (1989), Ricerche sugli arabismi italiani con particolare riguardo alla Sicilia, Palermo, Centro studi filologici e linguistici siciliani, Supplemento al Bollettino 10.
Pieroni, Silvia (2010), ‘Latino e italiano’, in ENCIT, 754-761.
Rohlfs, Gerhard (1966-1969), Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, 3 voll., Torino, Einaudi.
Rohlfs, Gerhard (1972), Studi e ricerche su lingua e dialetti d’Italia, Firenze, Sansoni. Rossi, Leonardo; Marongiu, Paola (2005), Breve storia della lingua italiana per parole, con Presentazione di Luca Serianni, Firenze, Le Monnier.
Sălișteanu, Oana (2017), ‘Alcune considerazioni sui fenomeni allotropici nel lessico italiano: voci ereditarie, voci dotte, voci semidotte’, in Guadagnini, Elisa; Vaccaro, Giulio (eds.), «Rem tene, verba sequentur». Latinità e medioevo romanzo: testi e lingue in contatto, Atti del convegno conclusivo del progetto FIRB – Futuro in ricerca 2010 «DiVo – Dizionario dei Volgarizzamenti. Il lessico di traduzione dal latino nell’italiano delle Origini» (Firenze, Villa Medicea di Castello, 17-18 febbraio 2016), 65-101.
Scavuzzo, Carmelo (1994), ‘I latinismi del lessico italiano’, in Serianni, Luca; Trifone Pietro (eds.), Storia della lingua italiana, 3 voll., Torino, Einaudi, vol. II (Scritto e parlato), 469-494.
Serianni, Luca (1998) [1988], Lezioni di grammatica storica italiana, Roma, Bulzoni.
Serianni, Luca (2005), Un treno di sintomi. I medici e le parole: percorsi linguistici nel passato e nel presente, Milano, Garzanti.
Serianni, Luca (2010), ‘Sulla componente idiomatica e proverbiale nell’italiano di oggi’, in Bertinetto, Pier Marco; Marazzini, Claudio; Soletti, Elisabetta (eds.), Lingua storia cultura. Una lunga fedeltà. Per Gian Luigi Beccaria, Atti del Convegno internazionale di studi (Torino, 16-17 ottobre 2008), Alessandria, Edizioni dell’Orso, 69-88.
Serianni, Luca (2015), Prima lezione di storia della lingua italiana, Roma-Bari, Laterza.
Serianni, Luca (2017), ‘Per una tipologia dei latinismi nei testi dei primi secoli’, in Guadagnini, Elisa; Vaccaro, Giulio (eds.), «Rem tene, verba sequentur». Latinità e medioevo romanzo: testi e lingue in contatto, Atti del convegno conclusivo del progetto FIRB – Futuro in ricerca 2010 «DiVo – Dizionario dei Volgarizzamenti. Il lessico di traduzione dal latino nell’italiano delle Origini» (Firenze, Villa Medicea di Castello, 17-18 febbraio 2016), 125-141.
Simone, Raffaele (2010), ‘Lingue romanze e italiano’, in ENCIT, 826-836.
Stammerjohann, Harro (2010), ‘Europeismi’, in ENCIT, 453-458.
Tagliavini, Carlo (1963), Storia di parole pagane e cristiane attraverso i tempi, Brescia, Morcelliana.
Tagliavini, Carlo (1982) [1949], Le origini delle lingue neolatine. Introduzione alla filologia romanza, Bologna, Pàtron Editore.
Tekavčić, Pavao (1980), Grammatica storica dell’italiano, 3 voll., Bologna, Il Mulino.
Tesi, Riccardo (1994), Dal greco all’italiano. Studi sugli europeismi lessicali d’origine greca dal Rinascimento ad oggi, Firenze, Le Lettere.
Tesi, Riccardo (2005), Storia dell’italiano. La lingua moderna e contemporanea, Bologna, Zanichelli.
Tesi, Riccardo (2007), La formazione della lingua comune dalle fasi iniziali al Rinascimento, Bologna, Zanichelli.
Tesi, Riccardo (2010), ‘Latinismi’, in ENCIT, 751-754.
TLIO = Tesoro della Lingua Italiana delle Origini, fondato da Pietro G. Beltrami, Firenze, Opera del Vocabolario Italiano, CNR, 1997 e segg., pubblicato in rete
Tommaseo-Bellini = Tommaseo, Niccolò; Bellini, Bernardo (1861-1879), Dizionario della lingua italiana, Torino, Unione tipografico-editrice
Trifone, Maurizio (2007), ‘Carbonaio è una parola di alto uso? Riflessioni sul Vocabolario di base e sul Dizionario di base della lingua italiana’, Studi di Lessicografia italiana 24, 265-300.
Zamboni, Alberto (1976), L’etimologia, Bologna, Zanichelli.
Zolli, Paolo (1989), Come nascono le parole italiane, Milano, Rizzoli.