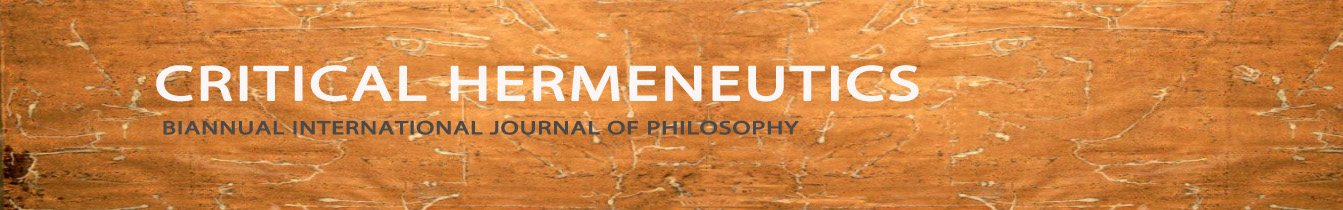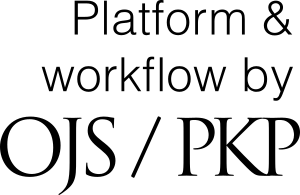Emilio Betti and the Social Function of the Jurist
Abstract
The essay studies the construction of the concept of jurist in Emilio Betti as an organic representative of society. He is not a political representative, with or without mandate constraint, nor a legal representative, who transfers interests and relates them. The organic representative is a longa manus, an authoritative extension of the best of society. Its authority, disregarding political power, can reconcile the interests at stake, say the law with the sentence, rebalancing social imbalances, which can also be caused by the laws themselves. The function of social rebalancing combined with equity understood not only as formal but substantial justice makes Betti’s theoretical tension a methodological tool possible for all the sciences of knowledge and also for the associated life in the footsteps of Aristotle’s Nicomachean Ethichs, Politics and Rhetoric. The decision-making choice of the jurist emerges as one of the most relevant legal issues of our time, that of due process. Its necessary solution, both on the level of the legislation of each state, and on the level of all the individual narratives of each procedural event, can find solid references in Betti’s Romanesque studies, starting from those on the seven Kings of Rome, up to those on the Roman praetor. It makes possible to distinguish the gnoseological and thoughtful decision-making of the jurist from that which puts an end to the state of exception of the politician theorized by Carl Schmitt. And it also makes allows to distinguish a logic based on a broad ethical and cultural vision of society, from a logic emptied of deontology and based only on syllogistic argumentation, in which the means can replaces the end.
Downloads
References
AA.VV. (1994). L’ermeneutica giuridica di Emilio Betti. A cura di V. Frosini – F. Riccobono.
AA.VV. (1996-2001). «Ars interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica».
Adorno, F (1970). Dialoghi politici e lettere di Platone. Voll. 2. Torino: UTET.
Aristotele, Etica nicomachea.
Aristotele, Politica.
Aristotele, Retorica.
Ascoli, M. (1991). L’interpretazione delle leggi. Saggio di filosofia del diritto (1928). Milano: Giuffrè.
Baratono, A. (1947), Il mio paradosso. In AA.VV., Filosofi italiani con-temporanei Critica e pedagogia dei valori. Como: Tipografia figli della provvidenza.
Betti, E. (1948). Le categorie civilistiche dell’interpretazione. Rivista italiana per le scienze giuridiche, 34–93.
Betti, E. (1951). Falsa impostazione della questione storica dipenden-te da erronea diagnosi giuridica. Rivista italiana per le scienze giuridi-che, 94–134.
Betti, E. (1968). Iurisdictio praetoris e potere normativo. Labeo, n. 14: 7–23.
Betti, E. (1971). Interpretazione della legge e degli atti giuridici (Teo-ria generale e dogmatica). Milano: Giuffrè, Milano.
Betti, E. (1990). Teoria generale dell’interpretazione. Milano: Giuffrè.
Betti, E. (1991). Diritto. Metodo. Ermeneutica. Scritti scelti, Milano: Giuffrè.
Bianco, F. (1998). Introduzione all’ermeneutica. Roma-Bari: Laterza.
Bleicher, J. (1980). Contemporary Hermeneutics. Hermeneutics as Method. Philosophy and Critique. London: Routledge and Kegan Paul; trad. it. il Mulino, Bologna, 1986.
Caiani, L. (1954). I giudizi di valore nell’interpretazione giuridica. Pa-dova: Cedam.
Caiani, L. (1955). La filosofia dei giuristi italiani. Padova.
Cervati, A.A. (2010). L’insegnamento di Emilio Betti e lo studio del diritto costituzionale. In AA.VV., Le idee fanno la loro strada. La teo-ria generale dell’interpretazione di Emilio Betti cinquant’anni dopo. Roma: INSR.
Calamandrei, P. (1942). La certezza del diritto e la responsabilità della dottrina. Rivista di diritto commerciale; oggi in Lopez de Onãte, F. (1968).
Cesarini Sforza, W. (1930). Volontà privata e autonomia. Rivista in-ternazionale di filosofia del diritto.
Cesarini Sforza, W. (1932). Problemi dominanti nell’odierna filosofia del diritto. Rivista internazionale di filosofia del diritto, 188–200.
Cesarini Sforza, W. (1948). Recensione al volume di Enrico Opocher, il Valore dell’esperienza giuridica. Rivista italiana per le scienze giuri-diche, 483–486.
Cesarini Sforza, W. (1949). Il diritto come arte. Rivista italiana per le scienze giuridiche, 401–407.
Cesarini Sforza, W. (1950). Osservazioni sulla scienza giuridica. Rivi-sta italiana per le scienze giuridiche, 28–48.
Cesarini Sforza, W. (1956). Idee e problemi di filosofia giuridica. Mi-lano: Giuffrè.
Cesarini Sforza, W. (1960). Norma giuridica e struttura sociale. Rivi-sta internazionale di filosofia del diritto, 127–131.
Cesarini Sforza, W. (1961). Il problema della giustizia. Rivista inter-nazionale di filosofia del diritto, 45–54.
Cesarini Sforza, W. (19632). Individuo e Stato nella corporazione. In Il Corporativismo come esperienza giuridica. Milano: Giuffrè, 165–187.
Cesarini Sforza, W. (1967). Vecchie e nuove pagine di filosofia, storia e diritto, voll. 2. Milano: Giuffrè [post].
Costa, P. (1976-77). Widar Cesarini Sforza: ‘illusioni’ e ‘certezze’ del-la giurisprudenza (in margine a Crocianesimo e cultura giuridica ita-liana di Antonio De Gennaro). Quaderni fiorentini, 5-6, 1031–1095.
D’Agostino, F. (1974). L’equità come limite trascendentale del diritto. Rivista internazionale di filosofia del diritto, 413–433.
De Francisci, P. (1951). Emilio Betti e i suoi studi intorno all’interpretazione. Rivista italiana per le scienze giuridiche, 1–50.
De Marini, C. M. (1957, 1959). Il giudizio di equità nel processo civi-le. Premesse teoriche. Padova: Cedam.
Esser, J. (1963). Wandlungen von Billigkeit und Billigkeitsechsspre-chung im Modernen Privatrecht. In Summum ius, summa ini-uria.Tübingen: Mohr.
Esser, J. (1972). Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfin-dung. Frankfurt am Main: Fischer Athenäum Taschenbücher; tr. it., Napoli: Esi, 1983.
Ferrajoli, L. (1989). Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale. Bari: Laterza.
Ferrajoli, L. (2021) La costruzione della democrazia. Teoria del ga-rantismo costituzionale. Roma: Laterza.
Ferraris, M. (1998). L’ermeneutica. Roma-Bari: Laterza.
Fioravanti, M. (1979). Giuristi e costituzione politica nell’800 tedesco. Quaderni fiorentini. Milano.
Fustel de Coulanges, N. D. (1891). Recherches sur le tirage au sort appliqué à la nomination des archontes athéniens. In Nouvelles re-cherches sur quelques problèmes d’histoire. Paris: Hachette, 147–179.
Galatello Adamo, A. (1987). Le mura e gli uomini. Società e politica in N.D. Fustel de Coulanges. Napoli:ESI.
Gerber, C. F. (1971). Diritto pubblico. Milano: Giuffrè.
Italia, V. (2010). Il disordine delle leggi e l’interpretazione. Milano: Giuffrè.
Kott, J. (1970). The Eating of Gods. Trad. it. Milano: Edizioni il Formi-chiere, Milano.
Lombardi Vallauri, L. (1967). Saggio sul diritto giurisprudenziale. Mi-lano: Giuffrè.
Lopez de Onãte, F. (1968). La certezza del diritto (1942). Milano: Giuffrè.
Marinelli, V. (1996). Ermeneutica giudiziaria. Modelli e fondamenti. Milano: Giuffrè.
Mengoni, L. (1996). Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi. Mila-no: Giuffrè.
Modugno, F. (2009). Interpretazione giuridica. Padova: CEDAM.
Mura, G. (2016). Ermeneutica e verità. Storia e problemi della filoso-fia dell’interpretazione. Roma: Lateran University Press.
Omero, Iliade.
Palmer, R. (2009). Che cosa significa ermeneutica? Lecce: Besa.
Paolo (San), Seconda lettera ai Corinzi.
Pareyson, L. (2005). Verità e interpretazione (1971). Milano: Mursia.
Pareyson, L. (2007). Interpretazione e storia (1939-1980). Milano: Mursia.
Passerin d’Entreves, A. (1970). La dottrina dello stato. Torino. Giap-pichelli.
Pastore, B. La simbolica giuridica: giudizio e processo, AA.VV., L’interrogazione del simbolo, Mimesis, 2015.
Petrillo, F. (1991). L’equità nell’ermeneutica giuridica di Emilio Betti. RIFD, n. 2.
Petrillo, F. (1997). Diritto e volontà dello stato nel pensiero di Gio-vanni Gentile. Torino: Giappichelli.
Petrillo, F. (2000). L’ermeneutica come metodologia giuridica in Emi-lio Betti. Torino: Giappichelli.
Petrillo, F. (2005). La decisione giuridica. Torino: Giappichelli.
Petrillo, F. (2011). Interpretazione degli atti giuridici e correzione er-meneutica. Torino, Giappichelli.
Petrillo, F. (2012). L’istituto giuridico della discrezionalità amministra-tiva nella teoria del diritto di Emilio Betti, in D. M. Cananzi e R. Righi (a cura di) Ontologia e analisi del diritto. Scritti in onore di Gaetano Carcaterra, vol. II. Milano: Giuffrè, 999–1027.
Petrillo, F. (2016). Interpretazione della costituzione tra positivismo della modernità e stato di sicurezza. Società e diritti, n. 2: 138–163.
Petrillo, F. (2019). Sul giusto processo nel capítulo VI del Título V della Costitución de la República de Cuba. In AA.VV., Costituzione e diritto privato. Una riforma per Cuba. Soveria Mannelli: Rubbettino.
Petrillo, F. (2020). Metodo giuridico e metodo ermeneutico. Dall’interpretazione nel diritto civile all’ermeneutica negli altri campi del sapere. In AA.VV., Dall’esegesi giuridica alla teoria dell’interpretazione: Emilio Betti (1890-1968). Roma: RomaTre-Press.
Plachy, A., La teoria dell’interpretazione. Genesi e storia dell’ermeneutica moderna. Milano: Giuffrè 1974.
Riccobono, F. (2017), Antikelsenismo italiano. Torino: Giappichelli.
Ripert, G. (1949). Le déclin du droit. Etudes sur la législation con-temporaine. Paris: LGDJ.
Romagnosi, G. D. (1832-1839). Introduzione allo studio del diritto pubblico universale. In Id., Opere. Firenze: Piatti.
Romagnosi, G. D. (1832-1839b). Istituzioni di civile filosofia. In Id., Opere, cit.
Scajola, V. (1932). Del diritto positivo e dell’equità. In Studi giuridici, vol. III. Roma: Anonima Romana, 1–23.
Schmitt, C. (1972). I tre tipi di pensiero giuridico (1934). In G. Mi-glio, P. Schiera (a cura di). Le categorie del politico. Bologna: Il Mu-lino, 247–275.
Vattimo, G. (1994). Oltre l’interpretazione. Roma-Bari: Laterza.
Zaccaria, G. (1984). Ermeneutica e giurisprudenza. Saggio sulla me-todologia ermeneutica di J. Esser. Milano: Giuffrè.
Zaccaria, G. (1996). Questioni di interpretazione. Padova: Cedam, Padova.
Zaccaria, G. (2020) Emilio Betti: un pioniere dell’ermeneutica misco-nosciuto. Perché? In AA.VV., Dall’esegesi giuridica alla teoria dell’interpretazione: Emilio Betti (1890-1968). Roma: RomaTre-Press.
Copyrights for articles published in Critical Hermeneutics are retained by the authors, with first publication rights granted to the journal.
Critical Hermeneutics is published under a Creative Commons Attribution Licence CC BY 3.0
. With the licence CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute and/or copy the contribution (edited version), on condition that credit is properly attributed to its author and that Critical Hermeneutics is mentioned as its first venue of publication.